ferdinand ossendowski (1922 )
Le usanze matrimoniali di una tribù della prateria ( tratto da "L'uomo e il mistero in Asia")
 Tutta
l’estate e fino ad autunno avanzato viaggiammo per le praterie che
si stendono fra i Monti Abakani e la Ferrovia Transiberiaiìa.
Visitammo la riva di sinistra del Jenissei, ove si accampavano i
Tartari Abakani, popolazione mista, composta di elementi lasciati
qui dalle varie genti mongoliche che vi passarono. I Tartari Abakani
resistono ad ogni innovazione: la loro civiltà è ancora quella del
secolo decimoterzo e del decimoquarto, i due secoli che stamparono
un’impronta tanto caratteristica negli ordinamenti politico e
sociali dell’Asia. La legge di Gengis, detta "legge della
prateria " si mescola con precetti del Colano e domina in
questi luoghi senza alcuna modificazione o alterazione di elementi
moderni.La famiglia presenta tutti i caratteri propri della
vita nomade e guerriera: la donna non èche un oggetto di piacere.
Essa non ha alcun valore, poichè il guerriero nomade, che domani
potrà cadere in battaglia, non vuole avere legami domestici
permanenti. Oggi la prende: domani la lascierà senza rimpianti;
quando è costretto a fuggire è capace anche di ucciderla col
coltello perché non cada in mano al nemico. Quando poi la vita del
nomade si svolge pacifica, allora la donna non è considerata che
come una bestia da fatica, costretta a lavorare dall’alba fino a
sera tarda. Non solo le è negata l’affezione pura, spirituale, ma
anche il rispetto. E tale mancanza di amore e di rispetto per la
donna chiaramente si rispecchia nella vita famigliare, in cui essa
è sempre una schiava; e solo un caso può sottrarla a tale destino.
Il Tartaro cerca le mogli fra le figlie dei conoscenti ma, secondo
il costume dell’Oriente, non solo non ne fa motto alla fanciulla
prescelta, ma non le rivolge nemmeno la parola. Manda certi doni al
padre di lei, al quale poi si presenta il sensale di matrimoni
dicendogli:
Tutta
l’estate e fino ad autunno avanzato viaggiammo per le praterie che
si stendono fra i Monti Abakani e la Ferrovia Transiberiaiìa.
Visitammo la riva di sinistra del Jenissei, ove si accampavano i
Tartari Abakani, popolazione mista, composta di elementi lasciati
qui dalle varie genti mongoliche che vi passarono. I Tartari Abakani
resistono ad ogni innovazione: la loro civiltà è ancora quella del
secolo decimoterzo e del decimoquarto, i due secoli che stamparono
un’impronta tanto caratteristica negli ordinamenti politico e
sociali dell’Asia. La legge di Gengis, detta "legge della
prateria " si mescola con precetti del Colano e domina in
questi luoghi senza alcuna modificazione o alterazione di elementi
moderni.La famiglia presenta tutti i caratteri propri della
vita nomade e guerriera: la donna non èche un oggetto di piacere.
Essa non ha alcun valore, poichè il guerriero nomade, che domani
potrà cadere in battaglia, non vuole avere legami domestici
permanenti. Oggi la prende: domani la lascierà senza rimpianti;
quando è costretto a fuggire è capace anche di ucciderla col
coltello perché non cada in mano al nemico. Quando poi la vita del
nomade si svolge pacifica, allora la donna non è considerata che
come una bestia da fatica, costretta a lavorare dall’alba fino a
sera tarda. Non solo le è negata l’affezione pura, spirituale, ma
anche il rispetto. E tale mancanza di amore e di rispetto per la
donna chiaramente si rispecchia nella vita famigliare, in cui essa
è sempre una schiava; e solo un caso può sottrarla a tale destino.
Il Tartaro cerca le mogli fra le figlie dei conoscenti ma, secondo
il costume dell’Oriente, non solo non ne fa motto alla fanciulla
prescelta, ma non le rivolge nemmeno la parola. Manda certi doni al
padre di lei, al quale poi si presenta il sensale di matrimoni
dicendogli:
< Il mio Kunak domani al sorger del sole cavalcherà
intorno alla tua jurta su di un cavallo baio e getterà al
suolo la cinghia col nodo ".
Di’ al tuo Kunak ", risponde l’interpellato, padre o
fratello, " che è un ladro; e se si avvicina ancora all’accampamento
verso sera ci sarà per lui una palla che non sbaglierà il segno
".
 Dopo
questo dialogo, che è di prammatica, il sensate riceve i ,doni per
sè e per l’amico che lo manda. Il fidanzato, fedele alla
promessa, cavalca intorno alla jurta e lascia cadere la
cinghia col nodo. Prima del tramonto i parenti della sposa le legano
le mani e la lasciano nella prateria coprendola con un velo. Al
tramonto arriva lo sposo, la tira su in sella e cavalca verso la jurta
di lei. A questo punto della cerimonia bisogna ch’egli abbia
gli occhi e gli orecchi bene aperti, e che tenga bene in mano il suo
cavallo.
Dopo
questo dialogo, che è di prammatica, il sensate riceve i ,doni per
sè e per l’amico che lo manda. Il fidanzato, fedele alla
promessa, cavalca intorno alla jurta e lascia cadere la
cinghia col nodo. Prima del tramonto i parenti della sposa le legano
le mani e la lasciano nella prateria coprendola con un velo. Al
tramonto arriva lo sposo, la tira su in sella e cavalca verso la jurta
di lei. A questo punto della cerimonia bisogna ch’egli abbia
gli occhi e gli orecchi bene aperti, e che tenga bene in mano il suo
cavallo.
Quando egli passa vicino ai campo, il padre o fratello maggiore
della sposa manda un grido d’allarme e fa fuoco mirando davanti
alla testa del cavallo. Se lo sposo non ha udito l’allarme, o se
non riesce a trattener subito l’animale, può darsi che sia
colpito. E il fatto non è raro, sebbene accada per un’altra
ragione’: un padre che sia vecchio e senza figliuoli in età da
combattere, incarica di tirar allo sposo uno dei suoi lavoranti.
Ora, se quel lavorante è innamorate della figlia del padrone e
conta, se gli riesce di sposarla, di diventare un libero cittadino
della prateria quando vede in pericolo le sue speranze tira proprio
a colpire, e magari dimentica di dar prima il grido d’allarme. Se
il colpo va al segno, il malcapitato sposo piomba giù di sella, e
la speranza rinasce nel cuore del servo mercenario, che corre a
slegare i polsi alla ragazza, e coglie magari il momento per
bisbigliarle una dichiarazione d’amore: poche parole crude,
schiette, libere come la natura nella prateria.
Se lo sposo riesce a portarsi la sposa nel proprio accampamento, la
depone a terra e le fa fare un giro fuori della tenda conducendola
per la cinghia; dopo di che taglia il nodo e la fa entrare nella sua
nuova abitazione. La cerimonia è finita; il giorno dopo la giovane
coppia invia ai parenti della sposa la kalym o dote,
costituita da bestiame, denaro e altri doni combinati in precedenza.
Questi matrimoni in cui conta solo la volontà del maschio, e la
donna non ha alcun diritto di opporsi, sono causa sovente di
tragedie. Ho già parlato della frequenza dei suicidi fra le donne
tartare. Ma altre tragedie nascono pure quando nel cuore della donna
comincia a schiudersi il fiore vermiglio dell’amore, e con ‘l’amore
viene la gelosia, selvaggia e spietata come quel selvaggio oceano di
pascoli erbosi" di sabbie, di nude roccie, di gelidi, crudeli
venti invernali.
Le donne conoscono il
segreto per preparare veleni con bacche di cicuta e con radici di
gazam, pianta misteriosa molto ricercata; per procurarsela le donne
giungono talvolta a rubare i cavalli più belli degli allevamenti
del marito. I dottori sciamari vengono loro in aiuto:
conoscono le proprietà medicinali e venefiche delle piante e con
queste preparano elisir d’amore e filtri e veleni infallibili per
le rivali, e magari anche per il marito .e signore.
Appena tre anni fa, quando ebbi occasione di ripassare per queste
praterie dove per secoli pascolarono a milioni i cavalli e il
bestiame, le trovai deserte. I Tartari se n’erano andati a
mezzogiorno, di là dal confine mongolo, per sfuggire al furore
delittuoso dei Soviet; l’erba era stata distrutta da incendi
appiccati a bella posta, o devastata dalle cavallette’.
Era il castigo di Dio, o la maledizione di Abuk Khan. . o la
vendetta delle ombre adirate dei grandi capi, degli eroi delle
tribù scomparse da secoli?
Vidi numerosi i cadaveri dei Tartari trucidati dai Bolscevichi, le
ossa delle pecore e del bestiame bovino delle loro greggie.
Presso il Lago Nero, ove vent’anni prima mi ero accampato col mio
dotto superiore e coi tre galeotti evasi, trovai le rovine
affumicate della raffineria del sale e delle abitazioni adiacenti.
Solo una capannuccia rimaneva, albergo del custode e della sua
famiglia che vi aspettavano la morte immancabile da un giorno all’altro.
Simbolo di quella vita tragica, disperata sulla cima della montagna
si ergeva, profilandosi netta contro il chiarore dolce del cielo
primaverile, la forma oscura di un lupo.
Stava là, immobile come una statua di bronzo. D’un tratto levò
‘la testa, protese il collo e cacciò un ululato lungo, ripetuto.
Quella voce avida e minacciosa pareva invocare la morte la rovina e
l’oblio.
 Dove
siete, anni della giovinezza? Dove siete, pensieri, ideali di quei
giorni? Era questo ciò che aspettavo dalla vita e dalla civiltà
quando, vagando fra questi dolmen, ascoltavo la voce dei secoli
morti e sognavo una civiltà feconda e vitale che venisse ad
arrestare la mano alla distruzione che minacciava queste popolazioni
morenti? Quand’io lavoravo qui per il progresso e la felicità
degli uomini, per assicurare un destino migliore a questa terra
sterminata così attraente nella sua semplicità primitiva, era
questo il quadro che m’aspettavo di vedervi nel futuro?
Dove
siete, anni della giovinezza? Dove siete, pensieri, ideali di quei
giorni? Era questo ciò che aspettavo dalla vita e dalla civiltà
quando, vagando fra questi dolmen, ascoltavo la voce dei secoli
morti e sognavo una civiltà feconda e vitale che venisse ad
arrestare la mano alla distruzione che minacciava queste popolazioni
morenti? Quand’io lavoravo qui per il progresso e la felicità
degli uomini, per assicurare un destino migliore a questa terra
sterminata così attraente nella sua semplicità primitiva, era
questo il quadro che m’aspettavo di vedervi nel futuro?
Era questo, insomma, ciò che mi aspettavo dal fenomeno più
violento del progresso, la rivoluzione, quando in nome del progresso
e per protestare contro l’ingiustizia criminosa del Governo Zarista
mi gettavo nel 1905 nel turbine della prima rivoluzione,
guadagnandovi, come ricompensa, di languire due anni nella prigione
dello Zar?
No! non questo chiedeva l’anima mia.
Si dice che la rivoluzione è progresso? Ma è sempre vero?
Il paese della morte e delle tombe nelle praterie fra Ciulym e
Minusinsk, con quella sua voce, col fruscio delle erbe disseminate
di pietre ha gludicato; e il giudizio è stato lo stesso che aveva
dato Hak, il giorno che ci separammo dai nostri strani compagni poco
lungi da Minusinsk, agli ultimi di settembre.
Andrà male adesso per noi, senza di voi; ma il vostro fato è ancor
più brutto. Noi attenderemo la nostra fine tra il freddo e la fame;
ma intorno a noi avremo le libere foreste. Invece voi nelle vostre
città avrete da lottare contro la perfidia e la malignità della
vita, che ogni giorno si fa più iniqua, più insidiosa. Voi
morirete, e morendo udrete le grida e i gemiti di coloro che
assassina la vita delle città ".
Ci strinsero la mano con effusione, ci guardarono fisso negli occhi
e tornarono verso la loro esistenza di bestie perseguitate. Andarono
via in fila, l’un dietro l’altro, come lupi che tornano’ a
celarsi nel folto, lungi dalle strade battute, lungi dai luoghi
abitati e dalla gente nemica. Sull’orlo della boscaglia si
fermarono a scrutarsi d’intorno, taciturni e vigilanti.


Nozioni sull'"Agarttha" in Occidente - Da Il Re del mondo (René Guénon)
L'opera postuma di Saint-Yves d'Alveydre intitolata Mission de l'Inde, pubblicata nel 1910,(1) contiene la descrizione di un centro iniziatico misterioso indicato col nome di Agarttha; fra i lettori di quel libro, molti probabilmente pensarono che si trattasse solo di un racconto del tutto immaginario, una sorta di finzione priva di qualsiasi fondamento reale. Vi si trovano infatti, se si vuol prendere tutto alla lettera, inverosimiglianze che, almeno per coloro che si attengono alle apparenze esteriori, potrebbero giustificare un tale giudizio; e Saint-Yves aveva senz'altro avuto delle buone ragioni per non pubblicare egli stesso quell'opera scritta tanto tempo prima e mai veramente portata a termine. D'altra parte, prima di allora, non era stata fatta menzione in Europa né dell'Agarttha né del suo capo, il Brahmâtmâ, se non da uno scrittore di scarsa serietà, Louis Jacolliot,(2) alla cui autorità non si può certo fare riferimento; da parte nostra, pensiamo che egli avesse realmente inteso parlare di quelle cose durante un suo soggiorno in India, ma per manipolarle poi, come tutto il resto, alla sua maniera eminentemente fantasiosa. Tuttavia nel 1924 è avvenuto un fatto nuovo e inatteso: il libro Bétes, Hommes et Dieux, nel quale Ferdinand Ossendowski racconta le sue peripezie nel corso di un laborioso viaggio compiuto fra il 1920 e il 1921 attraverso l'Asia centrale, contiene, soprattutto nell'ultima parte, racconti quasi identici a quelli di Saint-Yves; e i molti commenti che hanno accompagnato questo libro ci offrono, crediamo, l'occasione di rompere finalmente il silenzio sulla questione dell'Agarttha.
 Spiriti scettici o malevoli
non hanno mancato, naturalmente, di accusare Ossendowski di aver
semplicemente plagiato Saint-Yves, segnalando tutti i passi
concordanti delle due opere; e infatti ve ne sono parecchi che
presentano, anche nei particolari, somiglianze davvero sorprendenti.
Vi troviamo innanzitutto, cosa che poteva parere inverosimile anche
in Saint-Yves, l'affermazione dell'esistenza di un mondo
sotterraneo, le cui ramificazioni si estenderebbero dappertutto,
sotto i continenti e anche sotto gli oceani, e per mezzo del quale
si stabilirebbero invisibili comunicazioni fra tutte le regioni
della terra; Ossendowski, del resto, non rivendica la paternità di
una simile asserzione e anzi dichiara di non sapere cosa pensare in
proposito; la attribuisce invece a vari personaggi incontrati lungo
il viaggio. Passando a questioni più particolari, c'è il passo in
cui il "Re del Mondo" è raffigurato dinanzi alla tomba
del suo predecessore, quello in cui si parla dell'origine degli
Zingari, i quali un tempo avrebbero vissuto nell'Agarttha,(3)
e molti altri ancora. Saint-Yves dice che, durante la celebrazione
sotterranea dei "Misteri cosmici", vi sono momenti in cui
i viaggiatori che si trovano nel deserto si fermano, in cui anche
gli animali rimangono silenziosi;(4) 4 Ossendowski
sostiene di aver assistito personalmente a uno di quei momenti di
generale raccoglimento. E poi, fra le strane coincidenze, vi è la
storia di un'isola, oggi scomparsa, dove sarebbero vissuti uomini e
animali straordinari: a questo proposito, Saint-Yves cita il
riassunto del periplo di Iambulo fatto da Diodoro Siculo, mentre
Ossendowski parla del viaggio di un antico buddista del Nepal, e
tuttavia le loro descrizioni non differiscono quasi; se davvero
esistono due versioni di questa storia provenienti da fonti così
lontane l'una dall'altra, potrebbe essere interessante ritrovarle e
confrontarle accuratamente.
Spiriti scettici o malevoli
non hanno mancato, naturalmente, di accusare Ossendowski di aver
semplicemente plagiato Saint-Yves, segnalando tutti i passi
concordanti delle due opere; e infatti ve ne sono parecchi che
presentano, anche nei particolari, somiglianze davvero sorprendenti.
Vi troviamo innanzitutto, cosa che poteva parere inverosimile anche
in Saint-Yves, l'affermazione dell'esistenza di un mondo
sotterraneo, le cui ramificazioni si estenderebbero dappertutto,
sotto i continenti e anche sotto gli oceani, e per mezzo del quale
si stabilirebbero invisibili comunicazioni fra tutte le regioni
della terra; Ossendowski, del resto, non rivendica la paternità di
una simile asserzione e anzi dichiara di non sapere cosa pensare in
proposito; la attribuisce invece a vari personaggi incontrati lungo
il viaggio. Passando a questioni più particolari, c'è il passo in
cui il "Re del Mondo" è raffigurato dinanzi alla tomba
del suo predecessore, quello in cui si parla dell'origine degli
Zingari, i quali un tempo avrebbero vissuto nell'Agarttha,(3)
e molti altri ancora. Saint-Yves dice che, durante la celebrazione
sotterranea dei "Misteri cosmici", vi sono momenti in cui
i viaggiatori che si trovano nel deserto si fermano, in cui anche
gli animali rimangono silenziosi;(4) 4 Ossendowski
sostiene di aver assistito personalmente a uno di quei momenti di
generale raccoglimento. E poi, fra le strane coincidenze, vi è la
storia di un'isola, oggi scomparsa, dove sarebbero vissuti uomini e
animali straordinari: a questo proposito, Saint-Yves cita il
riassunto del periplo di Iambulo fatto da Diodoro Siculo, mentre
Ossendowski parla del viaggio di un antico buddista del Nepal, e
tuttavia le loro descrizioni non differiscono quasi; se davvero
esistono due versioni di questa storia provenienti da fonti così
lontane l'una dall'altra, potrebbe essere interessante ritrovarle e
confrontarle accuratamente.
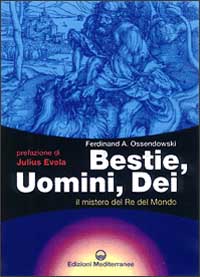 Abbiamo voluto segnalare
tutte queste concordanze, ma teniamo anche a dire che non ci
convincono affatto della realtà del plagio; è nostra intenzione,
del resto, non addentrarci in questa sede in una discussione che, in
fondo, ci interessa ben poco. Indipendentemente dalle testimonianze
che Ossendowski stesso ci ha indicato, sappiamo da altre fonti che
racconti di questo genere sono frequenti in Mongolia e in tutta
l'Asia centrale; e aggiungeremo subito che qualcosa di simile esiste
nelle tradizioni di quasi tutti i popoli. D'altra parte, se
Ossendowski avesse parzialmente copiato la Mission de l'Inde,
non vediamo perché avrebbe omesso certi passi di grande effetto, né
perché avrebbe cambiato la forma di certe parole, scrivendo per
esempio Agharti invece di Agarttha, il che invece si
spiega molto bene qualora egli abbia ottenuto da fonte mongola le
informazioni che Saint-Yves aveva ottenuto da fonte indù (di fatto
sappiamo che egli fu in relazione con almeno due Indù);(5) né
capiamo perché avrebbe usato, per designare il capo della gerarchia
iniziatica, il titolo di "Re del Mondo", che non figura
mai in Saint-Yves. Anche se si ammettessero certi prestiti, resta
sempre il fatto che Ossendowski dice talora cose che non hanno il
loro equivalente nella Mission de l'Inde, e che egli non ha
certo potuto inventare di sana pianta, tanto più che, essendo
interessato più alla politica che alle idee e alle dottrine, e
ignorando tutto ciò che riguarda l'esoterismo, è stato
evidentemente incapace di coglierne egli stesso l'esatta portata:
citeremo in proposito la storia di una "pietra nera"
inviata un tempo dal "Re del Mondo" al Dalai-Lama,
poi trasportata a Urga, in Mongolia, e scomparsa circa cento anni
fa;(6) ora, in molte tradizioni le "pietre nere" hanno un
ruolo importante, da quella che era il simbolo di Cibele fino a
quella incastonata nella Kaabah della Mecca.(7) Ecco un altro
esempio: il Bogdo-Khan o "Buddha vivente", che
risiede a Urga, conserva, insieme ad altre cose preziose, l'anello
di Gengis-Khan su cui è inciso uno swastika, e una placca di
rame che porta il sigillo del "Re del Mondo"; sembra che
Ossendowski abbia potuto vedere solo il primo di questi due oggetti,
ma ben difficilmente avrebbe potuto immaginare l'esistenza del
secondo; e in tal caso non gli sarebbe venuto più naturale parlare
di una placca d'oro?
Abbiamo voluto segnalare
tutte queste concordanze, ma teniamo anche a dire che non ci
convincono affatto della realtà del plagio; è nostra intenzione,
del resto, non addentrarci in questa sede in una discussione che, in
fondo, ci interessa ben poco. Indipendentemente dalle testimonianze
che Ossendowski stesso ci ha indicato, sappiamo da altre fonti che
racconti di questo genere sono frequenti in Mongolia e in tutta
l'Asia centrale; e aggiungeremo subito che qualcosa di simile esiste
nelle tradizioni di quasi tutti i popoli. D'altra parte, se
Ossendowski avesse parzialmente copiato la Mission de l'Inde,
non vediamo perché avrebbe omesso certi passi di grande effetto, né
perché avrebbe cambiato la forma di certe parole, scrivendo per
esempio Agharti invece di Agarttha, il che invece si
spiega molto bene qualora egli abbia ottenuto da fonte mongola le
informazioni che Saint-Yves aveva ottenuto da fonte indù (di fatto
sappiamo che egli fu in relazione con almeno due Indù);(5) né
capiamo perché avrebbe usato, per designare il capo della gerarchia
iniziatica, il titolo di "Re del Mondo", che non figura
mai in Saint-Yves. Anche se si ammettessero certi prestiti, resta
sempre il fatto che Ossendowski dice talora cose che non hanno il
loro equivalente nella Mission de l'Inde, e che egli non ha
certo potuto inventare di sana pianta, tanto più che, essendo
interessato più alla politica che alle idee e alle dottrine, e
ignorando tutto ciò che riguarda l'esoterismo, è stato
evidentemente incapace di coglierne egli stesso l'esatta portata:
citeremo in proposito la storia di una "pietra nera"
inviata un tempo dal "Re del Mondo" al Dalai-Lama,
poi trasportata a Urga, in Mongolia, e scomparsa circa cento anni
fa;(6) ora, in molte tradizioni le "pietre nere" hanno un
ruolo importante, da quella che era il simbolo di Cibele fino a
quella incastonata nella Kaabah della Mecca.(7) Ecco un altro
esempio: il Bogdo-Khan o "Buddha vivente", che
risiede a Urga, conserva, insieme ad altre cose preziose, l'anello
di Gengis-Khan su cui è inciso uno swastika, e una placca di
rame che porta il sigillo del "Re del Mondo"; sembra che
Ossendowski abbia potuto vedere solo il primo di questi due oggetti,
ma ben difficilmente avrebbe potuto immaginare l'esistenza del
secondo; e in tal caso non gli sarebbe venuto più naturale parlare
di una placca d'oro?
Queste poche osservazioni preliminari sono sufficienti per lo scopo che ci siamo proposti, poiché intendiamo rimanere assolutamente estranei a qualsiasi polemica e questione personale; se citiamo Ossendowski e Saint-Yves è solo perché quello che hanno detto può servire come punto di partenza per considerazioni che nulla hanno a che vedere con quanto si potrà pensare dell'uno o dell'altro, e la cui portata supera di molto le loro individualità e anche la nostra che, in questo ambito, non deve certo contare di più. Riguardo alle loro opere, non vogliamo dedicarci a una "critica del testo" più o meno inutile, ma fornire piuttosto indicazioni che, almeno per quanto ne sappiamo, non sono ancora state date da nessuno e che possono in qualche misura aiutare a chiarire quello che Ossendowski chiama il "mistero dei misteri".(8)
Note
1. La seconda edizione è
apparsa nel 1949.
2. Les Fils de Dieu, pp. 236, 263-267, 272; Le Spiritisme dans le
Monde, pp. 27-28.
3. Dobbiamo dire a questo proposito che l'esistenza di popoli
"in tribolazione", dei quali gli Zingari sono un esempio
fra i più impressionanti, è davvero qualcosa di molto misterioso,
che richiederebbe un attento esame.
4. Il Dr. Arturo Reghini ci ha fatto notare che ciò poteva avere un
certo rapporto con il timor panicus degli antichi; tale
accostamento ci sembra di fatto estremamente verosimile.
5. Gli avversari di Ossendowski hanno voluto spiegare questo fatto
sostenendo che egli aveva avuto fra le mani una traduzione russa
della Mission de l'Inde, traduzione la cui esistenza è molto
problematica dato che gli eredi stessi di Saint-Yves la ignorano. è
stato anche rimproverato a Ossendowski di scrivere Om, mentre
Saint-Yves scrive Aum; ma, se Aum è la
rappresentazione del monosillabo sacro scomposto nei suoi elementi
costitutivi, è pur sempre Om la trascrizione corretta che
corrisponde alla pronuncia reale in uso sia in India sia in Tibet e
in Mongolia; basta questo particolare per valutare la competenza di
certi critici.
6. Ossendowski, il quale ignora che si tratta di un aerolite, cerca
di spiegare certi fenomeni, come l'apparizione di caratteri sulla
sua superficie, supponendo che si tratti di un frammento di una
sorta di ardesia.
7. Si potrebbe fare un curioso accostamento anche col lapsit
exillis, pietra caduta dal cielo sulla quale, in determinate
circostanze, apparivano iscrizioni, e che viene identificata con il
Graal nella versione di Wolfram von Eschenbach. A rendere la cosa
ancor più singolare, sta il fatto che, secondo questa versione, il
Graal finì con l'essere trasportato nel "regno del Prete
Gianni" che taluni hanno voluto identificare con la Mongolia,
benché nessuna localizzazione geografica possa essere qui accettata
in senso letterale (cfr. L'ésotérisme de Dante, 1957, pp.
35-36; si veda anche più avanti).
8. Ci ha meravigliato apprendere, recentemente, che taluni volevano
far passare il presente libro come "testimonianza" in
favore di un personaggio di cui, nel momento in cui scrivevamo, ci
era ignota persino l'esistenza; opponiamo la più formale smentita a
qualsiasi asserzione del genere, da qualunque parte venga, perché
per noi si tratta esclusivamente di una esposizione di dati che
appartengono al simbolismo tradizionale e non hanno perciò nulla a
che vedere con "personificazioni" di sorta.